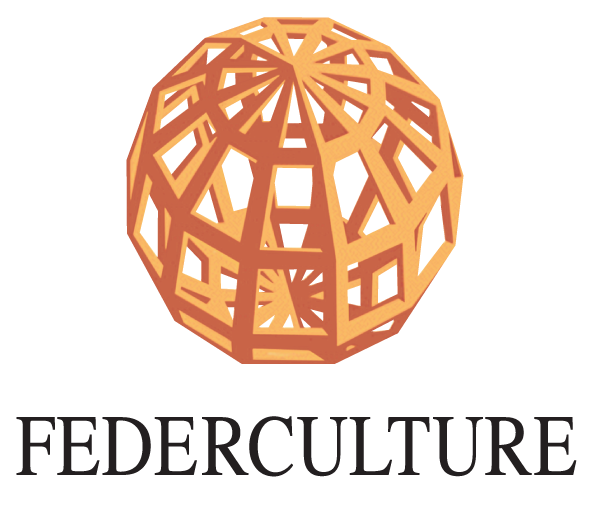Si è conclusa la ventesima edizione di Ravello Lab – Colloqui Internazionali, il forum europeo su cultura e sviluppo promosso dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, da Federculture e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, svoltosi a Villa Rufolo di Ravello dal 23 al 25 ottobre.
Il tema scelto per questa edizione, Turismi&Culture per la rigenerazione dei luoghi, ha guidato tre intense giornate di studio, approfondimento e progettualità condivisa. Anche quest’anno Ravello Lab si è confermato un laboratorio di idee e politiche per la cultura, capace di mettere in dialogo istituzioni, accademia, professionisti della cultura, operatori e amministratori pubblici.
La giornata centrale di venerdì 24 ottobre è stata dedicata ai tavoli di lavoro tematici, svoltisi a Villa Rufolo: “L’Italia dei piccoli borghi e delle aree interne”, “Le produzioni culturali per le trasformazioni” e “Capitali Italiane della Cultura: pratiche e impatti a dieci anni dall’istituzione del titolo”.
Tra le tante proposte emerse nella tre giorni si segnala l’idea lanciata da Stefano Sannino, Direttore Generale per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo (DG MENA) della Commissione Europea nell’ultima giornata di Ravello Lab durante la tavola rotonda sul tema Turismi&culture per la rigenerazione dei luoghi/ Riflessioni e commenti. In un momento storico particolarmente delicato e complesso e a pochi giorni dalla firma dell’accordo per un “nuovo Medio Oriente” a Sharm El-Sheikh, con cui l’Unione Europea ha rilanciato la propria visione di lungo periodo con un ambizioso “Patto per il Mediterraneo”, l’idea è di far nascere dopo le Capitali Europee anche le Capitali Mediterranee della Cultura. Un’iniziativa che mira a rafforzare le relazioni tra le sponde Nord e Sud del mare nostrum, con l’obiettivo di promuovere pace, stabilità e sviluppo condiviso.
Le riflessioni emerse dai tre tavoli saranno raccolte, come di consueto, nelle Raccomandazioni finali di Ravello Lab 2025, che verranno presentate nelle prossime settimane a Governo, enti territoriali e stakeholder pubblici e privati.
La ventesima edizione di Ravello Lab ha confermato il valore del dialogo tra cultura, turismo e innovazione come leve strategiche per lo sviluppo sostenibile dei territori. Nel solco della sua tradizione, il forum si conferma un punto di riferimento per la riflessione sulle politiche culturali e sulla loro integrazione con le strategie di crescita locale.
Anche quest’anno Ravello Lab ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e gode del patrocinio del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, dell’Università degli Studi di Salerno, della Conferenza delle Regioni, di ANCI, UPI, Provincia di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Unioncamere.
Fondazione Changes è main sponsor della XX edizione di Ravello Lab. Gli altri sponsor dell’appuntamento sono PA Foundation, Intesa Sanpaolo, SEF Consulting.
L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Ravello e Fondazione Ravello ed è sostenuto dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura, Regione Campania, Camera di Commercio Salerno, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Brescia Musei.
Infine, sono media partner della rassegna Q&A Turismo Cultura & Arte, Agenzia di stampa Cult, Equilibri Magazine rivista dello sviluppo sostenibile.
Per maggiori informazioni: http://www.ravellolab.org
Scarica il